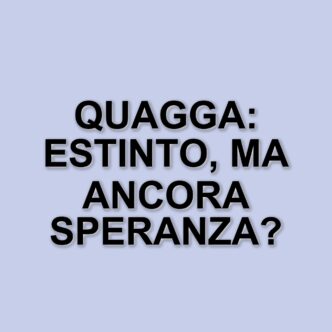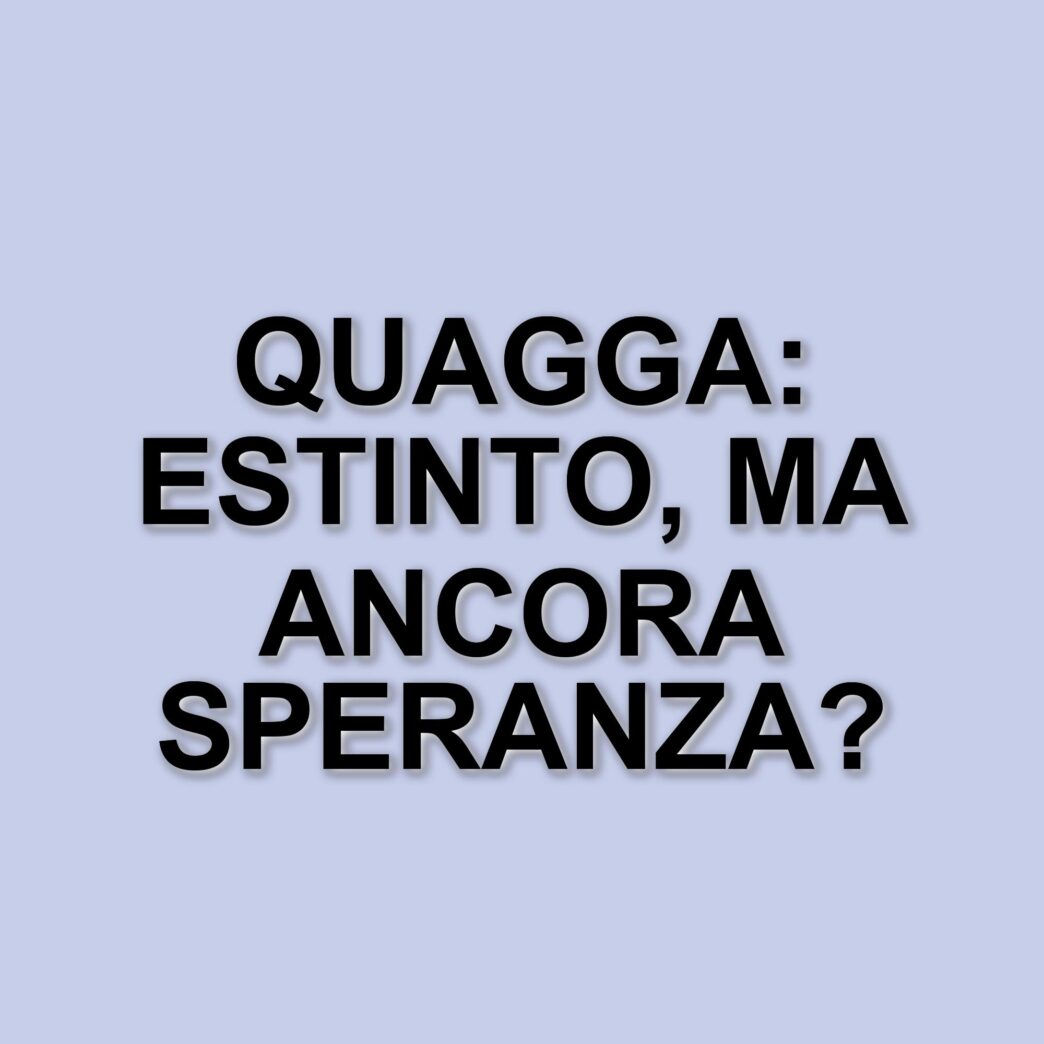Il quagga, una sottospecie di zebra di pianura, rappresenta un capitolo triste della storia naturale del Sudafrica. Questo animale, un tempo comune nelle praterie sudafricane, ha subito un rapido declino a causa dell’intervento umano e della caccia indiscriminata, portando alla sua estinzione avvenuta nella seconda metà del XIX secolo. Oggi, la sua memoria è custodita in pochi esemplari impagliati e in alcune fotografie storiche.
Origini e habitat del quagga
Il quagga era un equide che viveva principalmente nelle praterie del Sudafrica, in particolare nella regione del Karoo, a sud del fiume Orange. Questo animale, che presentava caratteristiche uniche, si distingueva per il suo manto striato solo nella parte anteriore del corpo, mentre la parte posteriore era priva di strisce, assumendo una colorazione uniforme che variava dal marrone-rossiccio al crema. La criniera era corta e dritta, mentre il ventre e la coda erano completamente bianchi.
Per lungo tempo, il quagga è stato considerato una specie a sé stante, ma studi genetici hanno rivelato che si trattava di una sottospecie della zebra di pianura. Nonostante le poche informazioni disponibili sul suo comportamento, si ritiene che il quagga vivesse in mandrie di 30-50 individui, simile alle zebre moderne, e trascorresse gran parte del tempo a brucare nelle aride praterie sudafricane. La sua adattabilità al clima variabile della regione era evidente nel folto mantello invernale, che cambiava con le stagioni.
Cause dell’estinzione del quagga
La storia del quagga è segnata da un declino drammatico, iniziato già all’inizio del XIX secolo. La caccia indiscriminata da parte dei coloni europei, che lo consideravano una minaccia per il bestiame e lo cacciavano per la carne e la pelle, ha avuto un impatto devastante sulla sua popolazione. Entro il 1850, le ultime mandrie di quagga sopravvivevano solo nello Stato Libero di Orange, ma furono rapidamente sterminate.
L’ultimo esemplare osservato in natura fu abbattuto nel 1878. In cattività, gli ultimi individui sopravvissero per qualche anno, ma nessuno riuscì a riprodursi. La famosa femmina fotografata allo zoo di Londra morì nel 1872, mentre l’ultimo quagga in cattività, una femmina allo zoo di Amsterdam, morì il 12 agosto 1883. La scomparsa di questo animale avvenne senza che nessuno si rendesse conto della sua estinzione imminente, e nel 1900 il quagga fu ufficialmente dichiarato estinto.
La memoria del quagga e i progetti di recupero
Oggi, il quagga è ricordato attraverso i pochi esemplari impagliati conservati in musei di tutto il mondo, tra cui due in Italia: uno al Museo di Storia Naturale di Milano e l’altro al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Tuttavia, la sua eredità non si è spenta del tutto. Negli ultimi anni, è stato avviato il “Quagga Project“, un’iniziativa che mira a “ricreare” una popolazione simile al quagga attraverso l’incrocio di zebre di Burchell, una sottospecie attualmente vivente.
Questo progetto, iniziato nel 1987, ha portato alla nascita di oltre cento zebre con strisce meno marcate, che assomigliano visivamente al quagga, ma che non possiedono il patrimonio genetico originale. Sebbene l’iniziativa abbia suscitato interesse e curiosità, è importante riconoscere che il vero quagga non potrà mai tornare. L’estinzione ha cancellato per sempre la sua unicità, e le zebre ottenute attraverso il progetto non sono altro che una ricostruzione estetica di un animale che non esiste più.
Il quagga rappresenta un monito sulla fragilità della biodiversità e sull’impatto che l’azione umana può avere sugli ecosistemi. La sua storia continua a ispirare discussioni sulla conservazione della fauna e sull’importanza di proteggere le specie a rischio di estinzione.
🔴Condividi coi tuoi amici!👇